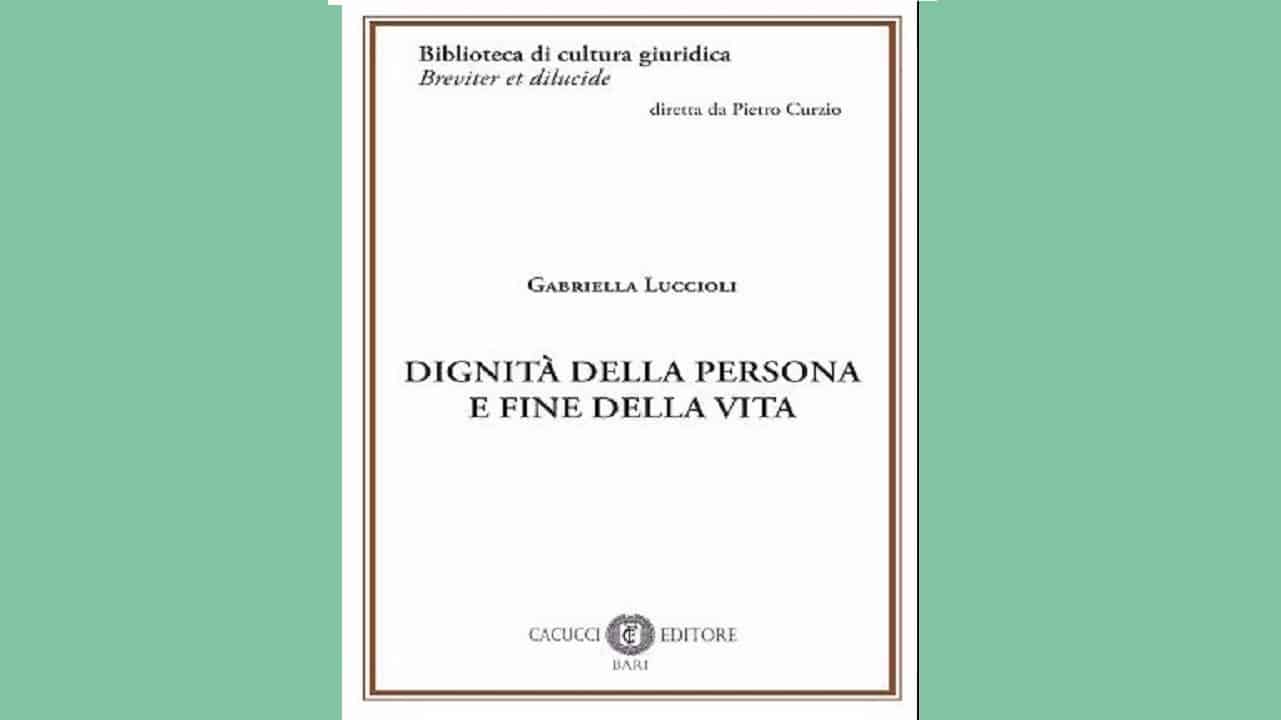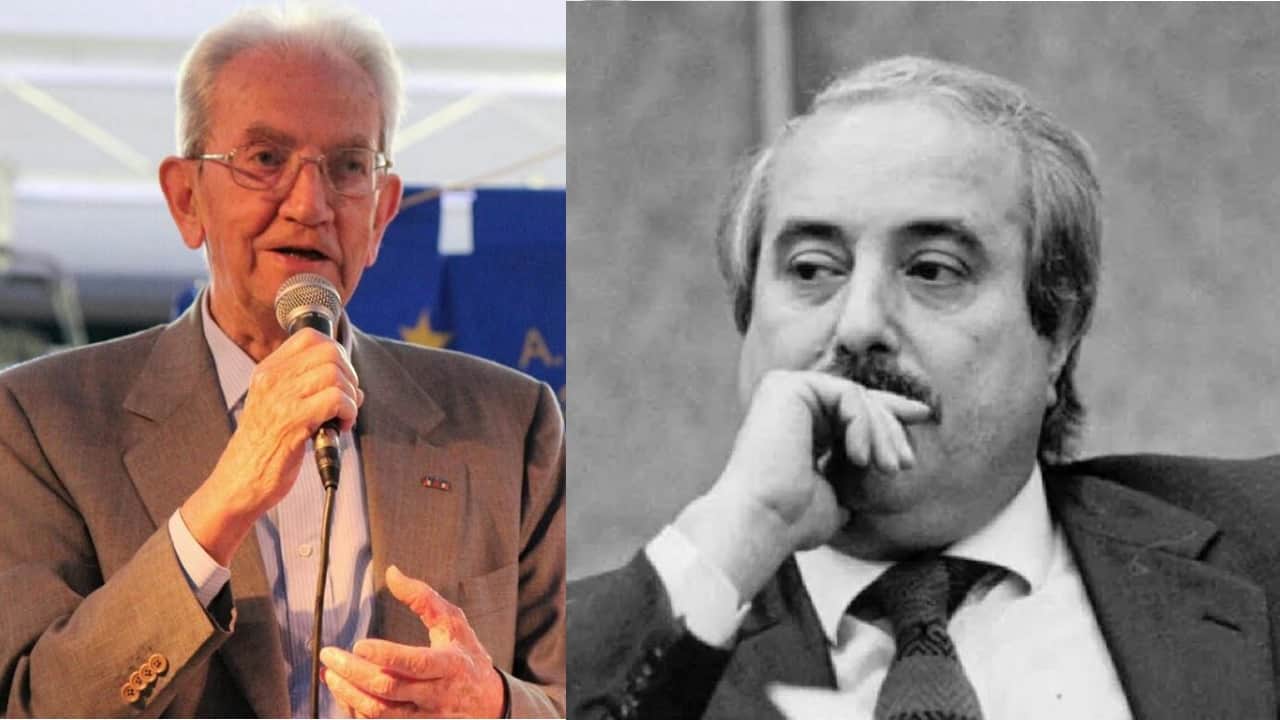La seconda edizione del volume curato da Benedetta Barbisan, che raccoglie le lezioni magistrali che Guido Calabresi ha tenuto presso l’Università di Macerata nel 2012, si configura come un’opera di notevole spessore per chiunque voglia approfondire il ruolo del giudice nella società contemporanea.
Questa nuova edizione non si limita a riprodurre integralmente le lezioni maceratesi, ma aggiunge una preziosa parte del volume dedicata alla rilettura della figura di Guido Calabresi, finemente proposta dalla curatrice Benedetta Barbisan.
Un contributo, quest’ultimo, assai importante per introdurre il lettore sia alle lezioni che alla seconda parte del volume[1].
Le lezioni di Calabresi affrontano temi cruciali per la giurisprudenza moderna, offrendo spunti di riflessione profondi sul ruolo del giudice che qui non serve ripercorrere analiticamente se non per ricordare solo alcuni dei tanti poliedrici aspetti affrontati dal giurista italo-americano. Nella prima lezione Calabresi offre una profonda analisi di come l’estrazione culturale e sociale del giudice sia determinante per comprenderne le decisioni, l’approccio interpretativo alla legge e la sua applicazione nel caso concreto. Questa riflessione è cruciale per il mestiere del giudice, facendo emergere l’essenza stessa del giudicare e dell’applicazione al caso della legge non è mai operazione meccanica, automatica e replicabile in modo stereotipo. Estendendo la riflessione al contesto italiano sembra di poter dire che i diversi orientamenti culturali all’interno della giurisdizione costituiscano elemento di ricchezza, pluralismo e garanzia dell’indipendenza del sistema giudiziario dagli altri poteri dello Stato e non patologia da eliminare, apparendo troppo superficiale l’accostamento di tale pluralismo al patologico correntismo che, diversamente, deve essere contrastato in modo efficace, serio e trasparente.
Un posto centrale nel pensiero di Calabresi occupa il tema del dialogo fra le corti nazionali e sovranazionali come elemento fondante dei sistemi democratici di protezione dei diritti fondamentali. Il dialogo, ci ricorda, attenua la ferocia repentina e drastica con cui il giudice assolverebbe il suo ruolo nel contesto giuridico moderno e riaccostandolo alla prudenza mite, incessante ma graduale, che apparteneva ai suoi predecessori della common law, al fine di aggiornare e migliorare il diritto. Questa affermazione, calata nei sistemi anglosassoni, viene indicata da Calabresi come elemento portante anche dei sistemi di civil law, quando afferma che "in Italia e in Europa si avverte un ritorno al tema del dialogo e del confronto". Il dialogo, egli sostiene, "rimane il modo fondamentale in cui le corti fanno il proprio mestiere e costituisce la parte centrale proprio del ruolo del giudice". Inoltre, Calabresi ricorda che il giudice, proprio perché è indipendente, deve nel suo ruolo cercare di fare in modo che le istituzioni, tutte le istituzioni, operino nell’ambito delle loro prerogative e dunque “facciano il loro mestiere".
Un altro aspetto fondamentale trattato da Calabresi è quello del ruolo contro maggioritario del giudice. Calabresi, pur muovendo da un’esperienza normativa e sistemica diversa da quella italiana, descrive come "la figura contro maggioritaria dei giudici" emerga, ad esempio, "quando la legislazione è discriminatoria, tratta in modo discriminatorio persone o gruppi per ragioni di razza, di religione". In tali situazioni, "il ruolo della giurisdizione è quello di tutelare i valori fondamentali anche nell’ipotesi in cui la maggioranza non sia in sintonia con questi valori fondamentali". È qui che il giudice va alla ricerca e non alla creazione, ma alla ricerca dello spirito più profondo che è all’interno di ciascuna esperienza nazionale e per queste ragioni può esercitare un ruolo anti-maggioritario, autentica “scelta strutturale” connessa al dovere della Corti di “proteggere valori fondamentali da pressioni popolari momentanee”, ma anche di aggiornare e migliorare le leggi esistenti quando la legislazione non è al passo con i tempi e non è in linea con la coscienza sociale. Tuttavia, Calabresi sottolinea anche l’importanza di cogliere "i limiti del contromaggioritarismo", la necessità di circoscrivere il ruolo contro maggioritario a seconda del contesto nel quale viene chiamato il giudice a operare, e la "consapevolezza degli autolimiti che il giudice deve riconoscersi". Si tratta di considerazioni di estremo rilievo che lo stesso Calabresi ebbe ad approfondire nell’intervista già ricordata[2].
Non meno importante è l’accentuazione del carattere funzionale dell’attività giurisdizionale alla protezione effettiva e reale dei diritti. In questo senso, la sottolineatura circa la necessità di risposte giudiziarie che siano al tempo stesso sobrie nella esposizione dei motivi quanto efficaci si ritrova ripetutamente nelle lezioni maceratesi.
Calabresi ricorda che "per un giudice, a differenza del poeta, non importa scrivere bene, perché quello che conta è scrivere chiaro, scrivere con lucidità, e saper scrivere così viene solo dopo che uno ha capito, ha veramente capito. Poi, se un giudice scrive bene, tanto meglio". Questo messaggio, quello della chiarezza e della effettività e sinteticità, che si rivolge indiscriminatamente ai giudici di merito quanto ai giudici di legittimità, pervade il sistema giudiziario nel suo compiuto percorso e costituisce un valore della giurisdizione, tanto per il giudice di ultima istanza che per quello di merito, chiamato a dare un senso alle decisioni del giudice di legittimità e ad esse a sua volta compreso e comprensibile da chi ha chiesto giustizia.
Nella seconda lezione di Calabresi approfondisce, fra l’altro, il tema dell’autonomia del giudice americano pur se di nomina politica, illustrando come la carica a vita negli Stati Uniti funga da presidio contro le influenze politiche – … un presidente sceglie i giudici per affinità ideale o politica, ma resta in carica solo per quattro o, al massimo, per otto anni, mentre un giudice federale può rimanere alla sua Corte per decenni – permettendo al giudice di modificare le proprie opinioni nel tempo e di distanziarsi dalle posizioni iniziali che ne avevano determinato la nomina. Questa distanza dalla politica quotidiana, unita alla diversità delle estrazioni culturali e all’evoluzione umana della sensibilità, rende difficile affiliare rigidamente un giudice a un unico sistema di pensiero, ed invece rendendolo il giudice adatto “a difendere certi valori fondamentali dagli attacchi che, in quel momento storico, sono maggioritari.” Riflessione quanto mai attuale per comprendere le vicende oltreoceano.
La terza lezione maceratese si addentra poi in un tema di profonda riflessione etico-costituzionale e si snoda lungo un itinerario che vuole indagare, in modo profondo, sul rapporto tra giudice e giustizia, esaminato attraverso il tema della pena di morte nel sistema americano. Calabresi considera la pena di morte "uno dei più inaccettabili abomini nella cultura del diritto" e qualcosa che "è avvertito da lui come incorreggibilmente ingiusto".
Per illustrare la complessità di questo dilemma, Calabresi ricorre a due aneddoti significativi che hanno segnato la sua vita. Dapprima l’esperienza del contadino bolognese nel dopoguerra, che ospitò prima partigiani ed ebrei e poi tedeschi in fuga, ricordando una parte del dialogo che aveva avuto con il protagonista di quei gesti diversamente interpretati e compresi e riportando quel che ricordava essergli stato detto per spiegare i gesti umanitari nei confronti dei nazisti: "quando sono arrivate qui in campagna da me quelle persone erano tutte in difficoltà erano tutti ugualmente figli di mamma”, poi aggiungendo che non era il suo ruolo, quello di stabilire ciò che era giusto e ingiusto. “Il giusto e l’ingiusto lo capiscono a Roma”. È qui che Calabresi si chiede “quale verità” si nascondesse nelle parole di quel contadino offrendo questa risposta: “Non giudicare, perché sarai giudicato”. Un insegnamento che, divenuto poi giudice, Calabresi prova a rendere concreto nel suo approccio al tema della pena di morte.
Dall’altro lato Calabresi offre agli studenti maceratesi il ricordo dell’episodio occorso al padre, medico ed assistente di un noto clinico che, pur antifascista, aveva ottenuto dei finanziamenti per creare un nuovo padiglione all’interno dell’Istituto in cui operava. Chiamato a presenziare all’inaugurazione dell’opera realizzata al posto del Direttore, Calabresi racconta che il padre, alla presenza di Mussolini aveva pensato di ucciderlo: "Sarebbe facilissimo. Potrei afferrare un bisturi e indisturbato mettere fine alla sua vita e con essa al regime". Da quel proposito aveva tuttavia desistito “non per paura, semplicemente non avrebbe mai potuto farlo perché si trattava comunque di un’altra persona". Questi racconti illuminano la tensione tra imperativi etici e il ruolo del giudice vissuta e trasmessa da Calabresi. Ed è qui che comincia a delinearsi il dilemma per il giudice, un’ulteriore scelta dilemmatica fra legge e ciò che si pone come ingiusto. Cosa avrebbe fatto Calabresi se si fosse trovato a decidere un appello ad una sentenza che aveva pronunziato la condanna capitale?
Certo, un giudice che distorca la legge, che la interpreti e forzi a suo piacimento, non onora la lealtà della Costituzione su cui ha giurato, anche se il movente può essere moralmente commendevole, poiché il dovere del giudice è di applicare la legge. Non di strizzarla per far uscire dalle parole il significato che preferisce. Ma questo non basta per trovare risposta al dubbio. Calabresi scarta l’ipotesi delle dimissioni o di non partecipare al collegio in un caso di pena capitale, definendola "una via d’uscita sbagliata, simile a quella di Ponzio Pilato, voltarsi dall’altra parte per evitare di guardare quel che succede".
Invece, propone di "partecipare alla complessità del caso, non tirandosi indietro", osservando che "se tutti i giudici contrari alla pena di morte avessero ricusato quei casi, non sarebbe restato altri che giudici a favore della pena di morte senza nessuno scrupolo morale".
Per i casi estremi, come quelli di sistemi intrinsecamente ingiusti quali il fascismo e il nazismo, Calabresi teorizza la figura del "rivoluzionario in toga", un giudice che ha "l’obbligo morale di diventare un rivoluzionario", offrendo "un completo ostruzionismo a tutte le leggi ingiuste di quel paese, pur di minare dall’interno il regime". Un mestiere che, in un contesto totalitario e contrario alla dignità dell’uomo, diventa pericolosissimo e che richiederebbe lo stesso coraggio del padre di Calabresi, cioè di “essere capace di continuare a svolgere il mio mestiere offrendo un completo ostruzionismo a tutte le leggi ingiuste di quel paese, pur di minare all’interno il regime”.
In ben diversi – almeno fino ad oggi – contesti quali quelli occidentali, se non è possibile trovare un errore legale evidente che lo conduca a non applicare la legge e la pena di morte il giudice può "allegare un’opinione concorrente che parli alla storia che proclami la fondamentale ingiustizia della pena capitale, le ragioni per cui la Corte Suprema sia in errore e con questa opinione concorde corrente potrebbe orientare i casi futuri".
Il dilemma tra la lealtà alla legge e la spinta morale a salvare una vita rimane per Calabresi senza una risposta definitiva nella lezione dedicata ad un suo immaginario ruolo di giudice che lo portava comunque ad interrogarsi sull’essenza del giudicare che scolpisce con un’immagine molto bella: “svegliarsi nel cuore della notte è parte imprescindibile del mestiere di giudice, non solo nei casi dai risvolti tragici, ma anche in quelli in cui l’ingiustizia non sembri, poi tanto tragica". Il che vuol dire scavare, interrogarsi, non allontanare il dubbio ma portarlo con sé nel suo ambito professionale e umano. La sua riflessione si chiudeva, così, senza risposte definitiva, solo comunque augurandosi di non dover mai occuparsi di un caso simile e con un’unica certezza: "si fa il proprio meglio e si chiede perdono".
Dalla fine delle lezioni maceratesi prende l’abbrivio l’inizio della seconda parte del volume, dedicato alla rilettura della figura di Guido Calabresi e del suo mestiere di giudice da parte di Benedetta Barbisan. Si tratta di una davvero preziosa parte aggiunta di questa seconda edizione, fin dall’inizio impegnata nell’ambizioso – e pienamente riuscito – obiettivo di tracciare la complessa personalità intellettuale e professionale di Calabresi.
Barbisan prende le mosse dal giambo di Archiloco, che attraverso la rappresentazione di due animali, la volpe e il riccio, offre una bussola per cogliere la prospettiva che anima le persone e la loro ragion d’essere.
La volpe, mero conoscitore del mondo e della sua pluralità, cerca di tenere insieme in una visione olistica i diversi punti senza volerli ridurre ad unità. Il riccio, invece, è un autentico "cercatore di verità", assetato di verità e per questo teso a unire anche ciò che appare a prima vista impossibile coniugare in modo armonico. Barbisan disvela, all’interno di questo "libro nel libro", la poliedrica personalità di Calabresi, al tempo stesso volpe e riccio, in un continuo alternarsi di prospettive e di accenti, a seconda del ruolo da lui svolto nel panorama mondiale dello studio del diritto, sia come accademico, sia come giurista, sia come giudice.
Rifugiato “dentro e per sempre” e non solo per il periodo iniziale americano e per questo naturalmente ispirato da un’ansia di protezione verso chi si trovava nella medesima condizione da lui vissuta realmente, Calabresi scolpisce le sue sentenze in materia di protezione dei rifugiati con impressi i ricordi dell’allontanamento forzato dal suo paese e delle travagliate vicissitudini familiari occorse ai parenti rimasti in Italia proprio nella convinzione che i valori fondamentali meritano di essere salvaguardati con particolare vigore quando riguardano persone vulnerabili e fragili.
Il ritorno alle origini funge da pietra angolare della giurisprudenza di Calabresi consentendo di evitare che i guasti da lui subiti e vissuti possano ripetersi in futuro sugli altri. Qui si manifesta anche la missione universale del giurista, rivolta alla decisione di casi concreti, ma anche a lasciare testimonianza per il futuro. Ciò si racchiude nell’espressione, molto bella, usata da Barbisan quando ci dice che per Guido la missione è quella di "finalizzare sempre la discussione sui casi e sulle norme al vero scopo per cui li si studia, ovvero chiedersi che cosa si possa fare per rendere il mondo un posto migliore".
Questa premessa è fondamentale per comprendere quanto esposto nella narrazione di Barbisan, vissuta insieme a Calabresi, che in più punti entra come protagonista diretto e vivo per animare l’esperienza forte che l’autrice vuole trasmettere al lettore quando ci racconta che il film immaginario del processo sulla pena di morte inscenato da Calabresi con gli studenti era diventato, negli anni successivi alle lezioni, autentica, viva – e non meno tragica – rappresentazione teatrale vissuta realmente da Calabresi quale giudice di appello della Corte federale di New York.
Barbisan rilegge i fatti del processo ed i protagonisti, li mette insieme e li riannoda con grande abilità letteraria, riuscendo in modo davvero godibile a cogliere quella passione "costituzionale" con la quale Calabresi si accostò a quel caso che si unisce ed immerge nella vita del processo reale, nella vita dell’imputato condannato a morte, nella sua attesa per il verdetto di appello, fino ad entrare nelle viscere della decisione del caso, nella sofferenza, nella lacerazione del dubbio su cosa fare, quali argomenti utilizzare, come utilizzarli, come esternarli ai componenti del collegio, quanto dire e quanto non dire, con quell’ansia di verità non più solo rappresentata didatticamente ma realmente applicata.
Barbisan ci immerge nel cuore di questo "processo vissuto", descrivendo con intensità lo "scavo" meticoloso e le "notti insonni" che hanno caratterizzato la ricerca di verità di Calabresi. Di fronte a una bozza iniziale che confermava la condanna a morte, e con gli altri giudici orientati verso tale esito, Calabresi si trovò in un profondo travaglio. La sua unica via d’uscita, l’estrema risorsa per un giudice che non accetta di essere un mero automa di fronte a un’ingiustizia morale, sembrava essere la redazione di un’opinione dissenziente.
L’appassionata narrazione di Barbisan evidenzia come Calabresi e i suoi assistenti non si acquietarono a quella prospettiva, ma anzi si dedicarono per anni a una ricerca "spasmodica e certosina" della giurisprudenza di common law per trovare conferma di un vizio processuale talmente grave di giustificare l’annullamento della condanna. Un impegno che rifletteva il suo dovere, avvertito come non negoziabile da parte di Calabresi, di non applicare la legge automaticamente, ma di indagarla in profondità. Questo studio incessante portò, dopo anni, alla scoperta di un precedente che permise di identificare un prejudicial error negli errori procedurali del pubblico ministero. Tali errori, come le domande tendenziose e i commenti sulla difesa, sebbene singolarmente non gravissimi, nella loro combinazione furono ritenuti sufficienti a invalidare il processo di primo grado. Barbisan sottolinea come, grazie a questa dedizione e alla capacità di Calabresi di persuadere i colleghi, la condanna a morte fu annullata, e il nuovo processo si concluse con l’ergastolo. L’opinione dissenziente, pur non essendo mai stata formalmente depositata, rimane un documento di straordinario valore storico-giuridico, testimonianza della sua incrollabile ricerca di giustizia del Giudice Calabresi.
Il discorso dovrebbe volgere al termine come il volume qui recensito ma... riporta il lettore, quasi incredibilmente ed imprevedibilmente ad un’opera letteraria di notevole valore, storico, letterario e sociale.
La rilettura della vicenda sulla pena di morte, così intensamente vissuta da Calabresi, trova un’eco suggestiva nel romanzo Il piccolo giudice di Leonardo Sciascia, edito nel 1987. Questo accostamento riporta la riflessione a una dimensione che è al contempo reale e letteraria, dove la complessità del ruolo giudiziario, le sue implicazioni etiche e la ricerca della giustizia si fondono in un’unica, potente narrazione, ancora una volta dimostrando quando diritto e letteratura seguano binari destinati ad intrecciarsi sempre di più.
Sciascia, infatti, descrive l’atmosfera creatasi attorno al piccolo giudice che, in pieno regime fascista, con la sua decisione di non condannare a morte l’imputato pluriomicida, aveva rovinato una brillante carriera, affermando la sua opposizione al regime. La "piccolezza" di quel Giudice era, per Sciascia, misura della sua grandezza di fronte a sfide ben più grandi di lui. Il giudice di Sciascia, come Calabresi, si confronta con il dilemma morale, dialogando con un giurato che confessa di aver partecipato alla giuria proprio per opporsi alla pena di morte, seguendo la linea tracciata dal giudice. Il giudice stesso rivela di aver visto quel processo come il "punto d’onore" della sua vita, nonostante gli fosse stato consigliato di sottrarsi.
Entrambi i giudici, quello reale e quello letterario, affrontano il travaglio interiore. Il giudice di Sciascia, pur consapevole del rischio di annullamento della sentenza, è convinto di aver fatto il proprio dovere di uomo e di giudice, pur provando paura. Una paura che anima lo stesso Procuratore della Repubblica che in quel processo si era dichiarato apertamente favorevole alla pena di morte e lo aveva anzi invitato a prendere in considerazione la possibilità di astenersi dal processo, conoscendo la sua avversione alla pena capitale.
Di fronte all’accusa di cercare un alibi, una scappatoia che lo avrebbe posto “fuori” dal diritto il piccolo giudice ammette che la difesa del principio aveva contato più della vita dell’uomo, ma lo definisce un "problema, non un alibi". Egli aveva in questo modo salvato la sua anima e quella dei giurati. Sciascia riesce a descrivere in profondità il travaglio umano del giudice e dei giurati di fronte a una decisione sulla pena di morte, un senso del dovere e della ricerca del giusto nel rispetto della legge. Il giudice spiega le ragioni giuridiche per non applicare la pena capitale, pur ammettendo che la sua argomentazione potesse essere errata in diritto, ma ritenendo di aver svolto il proprio ruolo con coscienza e dignità.
Colpisce lo stesso approccio dei due "giudici" – il piccolo giudice e il Giudice Calabresi – rispetto al ruolo centrale della legge e del giusto.
Non vi è sovvertimento nel ricercare la giustizia, ma appunto consapevolezza che il diritto va letto, interpretato ed applicato all’interno di una cornice di valori fondamentali che lo innervano, lo vivificano, lo colorano delle esperienze culturali, personali e umane che ciascun giudice ha vissuto e che lo rendono appunto ogni volta insostituibile nelle vicende che saranno da lui esaminate. Un ruolo proattivo ma sempre e solo “umano” e non per questo eversivo, anzi risultato tutto circoscritto dal rispetto della legge, da una costante ricerca di verità. Concetto nel quale entrano prepotentemente i valori della persona, la centralità della persona, la non negoziabilità della sua dignità.
Le comparazioni sono continue. Entrambi i giudici si chiedono se rinunciare o abdicare al loro ruolo, pur essendo contrari alla pena di morte, ma giungono alla stessa conclusione. Entrambi non si tirano indietro e dismettono apertamente l’abito di Ponzio Pilato. Sono disposti a sacrificare tutta la loro carriera in nome della salvaguardia di valori essenziali per l’umanità. Si mettono in gioco entrambi con la loro esperienza personale, sentendo il valore della legge allo stesso modo.
Un elemento comune e potente che fa da sfondo alle loro scelte è l’antifascismo. Per il piccolo giudice di Sciascia, l’opposizione al regime è un contesto in cui opera la sua decisione. Per Calabresi, l’antifascismo non è meno intenso, avendo segnato profondamente la sua esperienza di vita, un’esperienza "senza radici" che lo ha portato a una profonda comprensione della necessità di difendere i valori fondamentali contro ogni forma di oppressione, guardando in particolare e con particolare intensità alle discriminazioni. Questo retroterra comune rafforza la loro determinazione a non piegarsi di fronte a ingiustizie sistemiche, anche a costo di gravi conseguenze personali e professionali.
In definitiva, il parallelo tra le lezioni di Guido Calabresi, il processo da lui realmente seguito e "Il piccolo giudice" di Sciascia evidenzia come il ruolo del giudice trascenda la mera applicazione della legge per toccare le corde più profonde dell’etica, della coscienza e della responsabilità umana. Una lettura unitaria delle diverse narrazioni conforta nell’idea di un legame pressoché indissolubile fra mondi non sempre capaci di riconoscersi e dialogare – quello accademico, quello giudiziario e quello letterario. Una visione olistica di questi contributi evidenzia che, di fronte a decisioni che riguardano la vita e la morte e, in genere, l’essenza dei diritti delle persone, il giudice è chiamato a un impegno che va oltre il tecnicismo giuridico, confrontandosi con le tavole delle leggi, i principi fondamentali ed anche con la propria anima e con la speranza di un mondo più giusto.
Ci piacerebbe chiedere a Guido se avesse mai letto il Piccolo Giudice e probabilmente non lo sapremo. Rimane in ogni caso una certezza, la grandezza del giudice Calabresi, giustamente celebrato in Italia[3] quale autentico alfiere e difensore della Rule of law, intesa come garanzia dei valori fondamentali di moralità e giustizia e dei diritti umani, con un appropriato bilanciamento tra questi ultimi e le necessità della società[4].
[1] Prima di ciò una doverosa premessa. L’avvicinamento alla figura umana e professionale di Guido Calabresi ha avuto inizio per chi scrive con lo studio quasi viscerale del famoso saggio scritto a quattro mani con il professor Philipp Bobbitt, Tragic choices, e si è sviluppato attraverso un rapporto epistolare a distanza durante l’epoca del Covid, poi sfociato nell’intervista impossibile ospitata da Giustizia insieme: v. Un’intervista impossibile a Guido Calabresi, di Roberto Conti, 13 settembre 2021.
[2] Un’intervista impossibile a Guido Calabresi, cit.: R.C. Esatto! Quando il Giudice si occupa dei diritti fondamentali sembra che vada contro la legislazione, sembra che si muova su posizioni alternative e quindi finisca col fare lui stesso il legislatore. Tutto questo, in definitiva, evoca il tema del giudice contro maggioritario. Essere contro maggioritario per un giudice è una possibilità, un’opportunità o un dovere? E quanto scelte contromaggioritarie rischiano di apparire devastanti rispetto a temi etici o religiosi (penso alla questione del crocifisso nei luoghi pubblici che tanto si agita in Italia) se giungono a risultati che danneggiano concorrenti diritti? G. Calabresi Procediamo per gradi. Prima di tutto ci sono certe situazioni in cui il dovere del Giudice è di essere “contro maggioritario”, ossia quando la legislazione è discriminatoria, ossia tratta male persone o gruppi per via di cosa sono, per ragioni di razza, per ragioni di religione, per ragioni di tante cose così, è proprio lì che un Giudice ha il dovere di essere contro maggioritario. Vorrei che fosse chiaro che noi Giudici non siamo come la maggioranza che dice “faccio…”, anche dopo la crisi del contro-maggioritarianismo al tempo di Roosevelt e della vecchia Corte Suprema. Ricordo che quando la Corte Suprema nel grande caso Carolene Products, 304 U.S. 144 (1938) ha detto che le Corti non debbono fare tante cose perché sono contromaggioritarie, ha incluso la famosa “nota 4” che ha detto “ma quando si tratta di discriminazione agire è un dovere del Giudice”, è un dovere. Per questo che Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954), e i casi che riguardano i gay, ecc., sono i casi in cui proprio spetta alla Corte agire. Teniamo conto anche, che quando si parla di discriminazione il potere del Giudice è sempre un po’ limitato. Ossia, se davvero la democrazia vuole certi valori, quando un Giudice dice “Ma non potete far questo discriminando!”, dà sempre alla maggioranza il potere di dire “Vogliamo fare quello ma non vogliamo discriminare e quindi siamo pronti a subire gli oneri che questa azione impone”. Intendo dire che questo diventa un modo di non essere contro maggioritario perché c’è sempre la possibilità di un “second look” legislativo. Questo è in contrasto con quando un Giudice dice invece “questa è una decisione di due process, invece che equal protection”. Detto questo, c’è anche… e questa è una cosa che proprio sento particolarmente di dovere dire ed ho nel cuore attualmente, c’è anche un problema quando la maggioranza fa qualche cosa non perché vuole discriminare, non perché vuole trattare male certe persone, ma perché la maggioranza vuole un risultato, ma lo vuole solo quando non ne subisce gli oneri. Ossia dice “facciamo questo…” non perché vuole discriminare verso quelli che subiscono gli oneri, ma perché gli oneri non sono sulla maggioranza. Quando la Polizia persegue i crimini legati al commercio di droga e lo fa solo nelle case dei poveri fa così non perché vuole discriminare contro i poveri, ma perché la maggioranza non essendo povera sa benissimo che “la polizia non verrà a casa mia!”. E io chiamo queste decisioni careless ossia “non mi importa”. E mi capita di osservare tali azioni di maggioranza spesso da quando faccio il Giudice.
Più volte mi accorgo di casi in cui ci sono violazioni dei diritti fondamentali, che non sono collegate a discriminazioni, quanto al fatto che si preferisce una prospettiva perché gli oneri sono altrove, e quindi “non mi importa”. Pensiamo invece ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Lì si parla del diritto di proprietà e c’è proprio scritto “si può prendere la proprietà ma si deve dare un risarcimento”, ossia “dobbiamo pagare”. Tutti noi desideriamo avere un parco o una bella strada se non ci costa. Ma la Costituzione dice che per averla dobbiamo pagare. Quindi c’è anche questo fenomeno meno evidente, meno diretto rispetto alle vicende in cui c’è discriminazione, nel quale il ruolo delle Corti è, e deve essere, particolarmente incisivo. Le Corti devono dire “quando si va vicino ad un diritto fondamentale e l’onere è messo solo sugli altri, siamo noi Corti a dire lo volete davvero? Siete pronti a subire gli oneri voi? Se no diciamo di no”. E questo è un dovere altrettanto forte anche se più sottile rispetto all’antidiscriminazione. Ma è una prospettiva d’importanza davvero notevole. Anzi, penso davvero che è quello di cui, se ho tempo perché è molto difficile, vorrei scrivere. Poi c’è il fatto di tante situazioni dove, quello che ha fatto la maggioranza è stata una cosa necessaria in un momento di crisi, per cui certi valori, certe libertà (non le libertà di cui le Costituzioni dicono “no questo non si fa mai e basta”) si possono limitare, ma solo quando c’è una crisi. Qui la Pandemia è stato un bell’esempio, perché alcune scelte deve prenderle la maggioranza e non spetta alle Corti dire “no”, perché è proprio la maggioranza che deve dire “c’è bisogno della vaccinazione, c’è bisogno delle mascherine…” e se le Corti si mettono a dire di no, perché sono cose che in certo senso limitano la libertà, questo è a mio avviso un grande errore.
Però, attenzione, quello che le Corti possono e devono forse fare, a crisi pandemica finita, è di dire alla maggioranza “state attenti che questa crisi è finita, diteci voi se volete queste cose davvero ancora o se è solo per inerzia che rimangono lì”. Anche questo è un obbligo che grava sulle Corti, un compito che non è contro maggioritario, perché richiama la maggioranza a fare quello che è il suo mestiere, ripensare e non perpetuare una scelta soltanto perché tempo fa, in periodo di crisi, venne adottata. Tutto questo discorso ci riporta alla nozione del dialogo, che in definitiva non è altro che un modo di parlare di queste cose. Poi ci sono tante cose che invece le Corti come la nostra Corte fanno, che possono sembrare contromaggioritarie perché contro la volontà della maggioranza di oggi, ma che invece sono maggioritarie, nel senso che fanno sì che persone che attualmente sono escluse dal popolo, dal diritto di votare, riescono ad esercitare i loro diritti come gli altri. In questo modo le Corti si assicurano che queste persone “escluse” possano parlare, partecipare al dialogo. In America questo fenomeno è stato particolarmente rilevante a proposito dei gay, che in quanto erano “closeted”, rinchiusi, non potevano discutere, professare e proteggere i loro diritti. Qui le Corti hanno espresso il principio che è importante che certi gruppi possano “parlare” così che poi possano far parte della discussione politica. Ecco, qui le Corti è come se portassero dentro alla discussione quei gruppi minoritari.
[3] Quasi in contemporanea v. Norman I. Silber, Outsider. Dentro e fuori. Storia di Guido Calabresi (trad. it.), Milano, 2025.
[4] G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008, 123.
Il volume di Guido Calabresi Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, seconda edizione a cura di Benedetta Barbisan, il Mulino, 2025 sarà presentato martedì 24 febbraio nel corso di una iniziativa online a cui è possibile partecipare collegandosi al link presente nella locandina